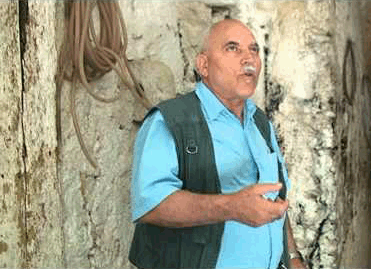 È il primo canto satirico o maccheronico-religioso riscontrato nel territorio montecalvese. Da informazioni raccolte, pare che esso sia stato introdotto a Montecalvo, verso la fine dell’Ottocento inizio Novecento, dai braccianti del paese, che si recavano a piedi, “cu zappa, zarrìcchji, stirràzza e na sacchètta ‘ncuóddru cu na shcanàta di pane, nu pócu di cumpanàggiu e na buttéglia di vinu” – con zappa, ghette, netta zappa di canna e un sacco addosso con una forma di pane, un po’ di companatico e una bottiglia di vino, a una trentina di chilometri di distanza, -VIDEO-
È il primo canto satirico o maccheronico-religioso riscontrato nel territorio montecalvese. Da informazioni raccolte, pare che esso sia stato introdotto a Montecalvo, verso la fine dell’Ottocento inizio Novecento, dai braccianti del paese, che si recavano a piedi, “cu zappa, zarrìcchji, stirràzza e na sacchètta ‘ncuóddru cu na shcanàta di pane, nu pócu di cumpanàggiu e na buttéglia di vinu” – con zappa, ghette, netta zappa di canna e un sacco addosso con una forma di pane, un po’ di companatico e una bottiglia di vino, a una trentina di chilometri di distanza, -VIDEO-
a zappare in autunno per la semina, a Torre Nocelle e a Sturno, dove si trattenevano per qualche settimana. È un canto che rappresenta una parodia, più che del Dies irae, di altri canti gregoriani, che i frati erano chiamati a intonare nelle messe funebri o sulle tombe dei defunti, nel giorno dei morti. Pur nella sua brevità, esso assume il carattere di una vera e propria burla. I figuranti, un sacerdote e un monaco, durante i lavori nei campi erano impersonati da due contadini. Il bersaglio non è né la chiesa né il clero, ma la classe dei ricchi proprietari terrieri locali e i massari. In questo caso un padrone, a cui è morta la cavalla, convoca un prete e un frate per celebrarne i funerali solenni, così come tradizione imponeva per i deceduti benestanti, vale a dire con una messa accompagnata dai canti gregoriani. Evidentemente, però, prima di portarsi sulla tomba della bestia morta, l’astuto prete ha trovato il modo di fare il giro della masseria, catturare un pingue tacchino e nasconderlo sotto i propri paramenti, indossati per l’occasione. Il frate, che ha afferrato a volo la questione, collabora alla tresca avvertendo il concelebrante che spuntano da sotto gli abiti le “zampe del Signore”. È un funerale che in ogni modo costa salato al ricco credulone, giustamente gabbato, una volta tanto, da chi è più abile di lui in certi affari. Oltre a rimetterci il tacchino, egli deve sborsare venti carlini e consegnare trenta biscotti ai due officianti. Indubbiamente questo canto, che assumeva tutti i toni di una recita farsesca, era motivo di gran divertimento e ilarità per i contadini durante i faticosi lavori nei campi. È probabile che in questo modo essi riuscissero pure a rimuovere o a esorcizzare la paura della morte, sempre incombente nel loro mondo. Il carrìnu, carlino, era una moneta che prese il nome da Carlo d’Angiò, che la fece coniare a Napoli nel XIII secolo. Molte altre monete, coniate nei secoli successivi, ebbero lo stesso nome. Canto di Mariantonia Del Vecchio, contadina (1922-2011); registrazione del 1988, trascrizione, traduzione e annotazione di Angelo Siciliano (imparò anche lui a cantare questo pezzo ed era motivo di divertimento coi parenti).{jcomments on}
|
Monaco: Calate chilòtt’e ccàmmisi, ca si vìdunu li cciàmpi Dòmini… Sac: Hai fattu buónu ch’hai parlàtu ‘n cèrmini, nun facìmu capì niénti a cquìssi tòndri… Duetto: Carrìni vinti e piscuttìni trenta e cquìssi vannu pi la bunàlima di la jummènta… |
Monaco: Abbassate cotta e camice, perché si vedono le zampe del tacchino...
Sac: Hai fatto bene a parlare in gergo, non facciamo capir nulla a questi stupidi...
Duetto: Carlini venti e biscottini trenta e questi vanno per la buonanima della giumenta... |




